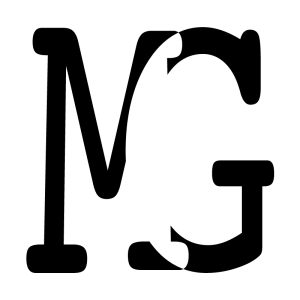Senza nome
L’odore acre dei muri, che ne hanno sentite tante davanti a una birra, circonda me e la mia ombra, lasciata lì in disparte da una vecchia lampadina appesa a un filo là sopra, a osservare il via vai e la solitudine.
Sopra il tavolo in legno un quotidiano locale piegato in due parti è più leggero: in tanti devono averlo sfogliato e dopo avergli tolto qualche parola l’hanno lasciato lì, ad attendere la sua fine del giorno dopo.
Il ritardo partorisce un tempo da cogliere e allora mi siedo sulla vecchia sedia, appoggio i gomiti sul tavolo in legno da otto e raccolgo il giornale: lo apro fino alle pagine dedicate alla cultura e leggo di un’analisi su un Vincent Van Gogh e la sua religione cristiana, presa con le pinze da chi non ha meglio da fare se non accorgersi di particolari per poter pubblicare un’opinione. Lo sguardo scorre sulle parole, sulle righe e sul quadro al centro della pagina, sulle mani nodose che tagliano e mangiano patate sopra un tavolo che forse somiglia proprio a quello su cui ora scarico la mia stanchezza e la mia attesa.
Intanto al bancone quattro conoscenti conversano col barista, ubriachi di birra e di una società che non capisce, non merita, non cresce.
Entrano dalla porta, che strilla il dolore acuto di una quotidiana condanna, vecchie coppie e giovani amicizie: è divertente come nonostante le diverse generazioni i comportamenti siano sempre gli stessi. Chi è solo è anche guardingo, serio e imbarazzato. Chi ha spalle su cui poggiarsi si mostra con sorriso beffardo e una sicurezza non sua. C’è anche chi entra e va dritto al bancone, perché è lì l’unico sostegno stabile della sua vita.
Mi alzo e a sostenere me è il muro freddo in pietra: sollevo il viso per osservare meglio l’ambiente e quel che vedo non è un bar, ma la seconda casa di chi nella vita crede di aver visto tutto, ma ancora non smette di cercare.

Io e Ed
Era una giornata soleggiata, senza ombre, nel deserto dell’Alabama.
Fiocchi di fieno attraversavano la strada come un tempo, quando le case erano di solo legno e chiodi.
La nostra macchina rombava al rumore dell’eco che il vento emetteva, tra la sabbia, la polvere e il terreno arido di una steppa incolta.
Viaggiavamo verso il tramonto, io e Ed.
Non sapevamo se fosse la strada giusta, ma guardavamo avanti.
Eravamo ignari di quel che si trovasse dopo l’orizzonte, ma certi che nemmeno un salto nel vuoto avrebbe fermato la nostra corsa.
Il contachilometri alternava i 100 e i 130: che ci importava della velocità? La strada era libera, la nostra auto sola nella routine della desolazione.
“Hei, Jack”. Ed e la sua voce rauca mi svegliarono di soprassalto. Ero caduto in un sonno malizioso di ordinaria pazzia, nel labirinto disincantato dei sogni.
“Dimmi” risposi seccato, scandendo ogni lettera a sottolineare il suo disturbo.
“è una luce o il whisky è ancora caldo?”. Avevamo bevuto molto all’ultima sosta, ma quella non era un’allucinazione.
Osservammo una serie di insegne luminose che apriva un varco nell’oscurità del deserto.
La solita strada continuava, ma il panorama del silenzio d’improvviso scomparve.
“È città, amico mio” dissi con tono divertito mentre, affascinato da quell’alba, capii che eravamo arrivati.
È lei. Finalmente.

Io e Ed – 2
Il muro di luci che ci apparve davanti dava quel senso di frastuono che si sente nei bar affollati di città, quando inserisci una moneta nel jukebox e inizia la canzone che hai scelto. Riesci ad ascoltarla soltanto di sottofondo, perché la gente fa baccano, parla in continuazione, non si ferma, nemmeno per un secondo. Le parole si mescolano tra loro e con il rumore dei bicchieri sparati in aria a brindare chissacché.
Questo era l’effetto che fece a me e Ed la città, quell’asciutto oceano che si apriva davanti a noi mentre ci avvicinavamo.
“Siamo arrivati! È… è…” non riuscivo a concludere la frase. Quelle luci mi distraevano e mi portavano lontano, a quel ’68 che non è mai più tornato e che in quel momento mi pareva di rivivere.
“No, Jack” sentenziò Ed amareggiato “non è questa New Orleans”.
Ed continuò a guidare e arrivammo al confine della città, dove le insegne luminose sembravano attendere il nostro passaggio.
Era New Iberia, ce lo dissero loro con quella faccia lampeggiante e ipnotica.
“La Lousiana è grande, amico, ma siamo vicini”.
Ammiro Ed, l’ho sempre ammirato. Lo conosco da una decina di anni, ma è come se avessimo giocato insieme da bambini. Immaginavo noi due che complottavamo contro una piccola banda di teppistelli del sud per attirare l’attenzione delle ragazzine. Quante ne avremmo combinate insieme.
Certo al college non ce ne siamo risparmiate. Fummo sospesi almeno tre volte in quattro anni, ma furono di più le volte che le guardie notturne non ci beccarono. Quei professori con la puzza sotto il naso dell’università erano abili solo nell’alzare il sopracciglio destro e fare quell’espressione d’altezzoso infastidito che odiavo. Ci guardavano dall’alto al basso con il vano tentativo di umiliarci di fronte agli altri ragazzi in classe e ci spedivano dritti dal direttore. “Siete una vergogna per l’istituto” sibilavano “questa è l’ultima bravata che commetterete”. Io e Ed, però, ogni volta sapevamo che non sarebbe andata come prevedevano. Infatti, la ramanzina ce la ripeterono in tanti, ognuno diverso. Il nostro sorriso beffardo era sempre lo stesso. Il direttore si limitava alle classiche raccomandazioni. Credo gli fossimo addirittura simpatici.
Erano begli anni, quelli. Le uniche preoccupazioni erano le ragazze e la quantità di birre.
Poi ci si è messo anche il whisky.

Io e Ed – 3
Nella sua mente c’era ancora qualcosa che non capivo.
Lo conoscevo da anni, ma ancora riusciva a sorprendermi con quei maledetti giochi mentali. Era come se sapesse sempre a cosa stavo pensando.
E allora tutto giocava a suo favore: dalla mano buona in un tavolo di poker alla scommessa nella stazione di servizio.
Non lo capivo, Ed, ma quel suo sguardo, perso lungo la strada, era molto chiaro, come il riflesso del tramonto sulle finestre ammassate della città.
Era fissato con un braccialetto, quello lasciato sul bancone del primo bar, all’inizio del viaggio, accanto al bicchiere vuoto bagnato dall’ultima schiuma della birra. Scendeva lenta e scandiva i secondi che l’avrebbero separato da lei.
Era una ballerina di charleston, una biondina niente male: capelli corti, una fascetta di brillanti legata attorno alla testa e una piccola piuma che le spuntava dalla nuca.
Suppongo però fosse il suo sorriso a farlo impazzire. Gli regalò quel braccialetto dopo che le ebbe offerto un drink, uno scotch&soda ghiacciato, e le disse qualche parola all’orecchio che non volle mai rivelarmi.
Aveva qualcosa in quello sguardo di ragazzina cresciuta troppo presto, qualcosa che svelava quando le si formavano rughe sbarazzine a ogni risata alle battute di Ed.
La lasciammo in quel locale, tappezzato di vecchia moquette e luci al neon, sotto l’insegna arrugginita con una luce tremolante che diceva “Sunshine”, con un po’ di melanconia e nostalgia.
Ed la guardò per l’ultima volta e anche se non la sfiorò nemmeno con un dito o con le labbra, sapevo che ne avrebbe portato con sé il profumo e quella sensazione di solitudine e tristezza. Oltre a quel bracciale, che come una reliquia lo teneva stretto nella tasca dei suoi pantaloni sgualciti e pieni di vita.
A volte mi fermavo a guardarlo, Ed, lo fissavo, per capirne qualcosa, afferrare quelle emozioni che non è mai stato bravo a mostrare, ma che vagano sopra la sua testa calda. Emozioni che invece con lei, la sua Cathrine, in quei cinque minuti all’ultimo saluto, sembravano staccarsi dalla sua anima per arrivarle sul viso come il fumo ispirato e lasciato andare.
Ricordo che persi la scommessa alla stazione di servizio. Non mi importavano i 20 dollari che dovetti dargli: azzeccò lui l’orario di arrivo e così tenne per sé quello che avrei voluto conoscere, le parole della donna al locale, la ballerina di charleston, che gli sussurrò all’orecchio sotto la vecchia insegna lampeggiante.

Io e Ed – 4
Eppure quella sera la luna sembrava proprio cantare, nascosta da quelle nuvole che come piume di struzzo le coprivano il viso, lasciandole accesi ancora quegli occhi, che sapevano chiedere e ottenere.
E come non darle ciò che voleva?
Ed me la descrisse così, quella sera, la luna. Seduto a cavalcioni sulla sedia, le braccia incrociate sullo schienale, la sigaretta che pendeva dalla bocca e lo sguardo fisso al cielo, in direzione di lei.
“Invaghirsi fa male, poi la vedi ovunque”, mi disse.
“Te ne sei innamorato, amico mio” gli risposi.
“Non sai quello che dici. L’amore non è nelle mie corde. Quel posto è della mia musica, l’unica compagna che avrò mai nella mia vita.”
“E lei è la tua musica ora, Ed.”
“Ingenuo e romantico, non cambierai mai: non riesci a distinguere quel che è solo poesia da un banale sentimento. Squattrinato e ridicolo come me, ma inguaribile sognatore. I cassetti rimangono chiusi, amico mio, nel mondo che abitiamo. Questa realtà non ha pietà di noi, svegliati.”
“Va bene, Ed, è come dici tu.”
Sarebbe stato inutile contraddirlo e per lui troppo difficile ammettere quanto gli stava accadendo.
Lei non era una fiamma, era la luna che stava lì, in quello che sarebbe stato sempre il suo unico tetto: il cielo.

Romanzo realtà
Hai presente quella fiamma che divampa da un minuscolo cerino quando lo strofini sulla superficie ruvida? Sì?!
Quella fiamma rappresenta le emozioni che ho provato e quella ruvida superficie sembra proprio a quella che aveva il mio cuore. Prima di conoscerti.
Dovevo cercare me stessa, ma non in un’altra persona: ero in me, dovevo solo ritrovarmi. O, chissà, trovarmi e basta, come fosse una prima volta.
Desideravo il mare perché forse mi sentivo proprio là, come fossi in balia delle onde e stessi cercando una vela a cui aggrapparmi.
Era lui la mia ancora. Ma come tutte le ancore mi aveva tenuta ferma, quasi immobile. Impigliata in uno scoglio quell’ancora mi teneva stretta a ciò che era e io, forse, mi sono limitata solo a seguire i movimenti che potevo fare trascinando la sua corda, mostrandole una direzione che, però, non potevo prendere.
Quella corda poi si è spezzata, ho lasciato la mia ancora e finalmente ho guardato il mare per quello che era. E ho incontrato te.
Una fiamma che è entrata nei miei occhi e mi ha liberato l’anima.
Imprevedibile come gli eventi che ti restano dentro, inaspettato come un’onda che sbatte sul molo e gli spruzzi ti accarezzano il viso, come quel sorriso che nonostante tutto ti appare. E ti cambia.
Perché sì, mi hai cambiato. Non ero sicura di aver trovato me stessa, ma la mia ricerca non era stata vana: mi sono trovata tra le mani e i pensieri il tuo sguardo, il tuo silenzio, la tua schiena.
Come quegli improvvisi spruzzi tu mi facevi sorridere senza motivo, con la stessa facilità con cui mi facevano arrabbiare alcuni tuoi comportamenti. Alcuni tuoi particolari che però, raccontandoli ora, mi mancano come aria.
Ma ho imparato a viverci senza l’aria. Ho imparato a condividere le sensazioni su pezzi di carta e ho capito che le parole non potranno mai descriverle, ma anche solo una penna può bastarmi a imprimerle su un’altra superficie.
Quelle promesse che leggevo nei tuoi occhi… perché non le hai mantenute? Erano solo mie interpretazioni, forse? Eppure no, non mi sono sbagliata, c’era qualcosa, ma entrambi abbiamo lasciato che quel fuoco ardesse. Non l’ho toccato, ma mi ha bruciato le mani lo stesso. E tu? Hai almeno percepito il calore?
Sì, tu c’eri. Eri nel bel mezzo di quel silenzio che ci ha tenuti stretti a tavola: ricordi quel giorno?
E quando ci eravamo promessi una serata insieme? Ho forse sbagliato a invitare qualcuno oltre a noi? Perché hai cambiato idea e rinunciato?
Ho molte domande da farti e a cui non risponderai. Sì, come le infinite che ti ho posto nei giorni in cui abbiamo condiviso spazi ed esperienze: un pezzo di vita che ha inciso sulla mia quotidianità il tuo nome, scolpito il tuo viso sull’orizzonte che guardo spesso. E che non ho più paura di affrontare.
Sì, come quella mattina all’aeroporto: un set di incontri che potevano avvenire, ma che si sono dissolti in rette non coincidenti. Possibile che siamo parallele? Forse, ma siamo linee unite dall’aria, vicine in un’atmosfera che abbiamo percepito, che ho tentato di farti comprendere in messaggi a cui non hai più risposto. Hai forse voltato un’altra pagina? Lo farò anch’io, ma tra quelle che parlano di te metterò uno dei miei segnalibri preferiti.

Sospensione
[poesia per progetto fotografico]
Se mi stai guardando, significa che hai riservato alcuni momenti della tua vita a un angolo solitario di un locale.
Alla tenerezza di una luce che si sorprende quando una figura in bianco e nero ti attrae.
Una luce di catrame che osserva, che cosa? Non ti guarda, ti accoglie.
Non dialoga con il tuo sguardo, ma percorre una linea che scolpisce la tua identità.
Resta immobile, non ha ancora concluso la sua opera.
Legge oltre la tua pelle l’origine della tua ombra.
Abbandona l’inquietudine, lasciati andare: cedi ai dettagli della tua vita e trova il coraggio di sorprenderti.

Desiderio
[poesia per progetto fotografico]
Dunque?
Cosa stavi cercando in quella scena?
Il tuo orgoglio? Quale desiderio?
Confidami la tua anima. No? Allora lo farò io.
Ti è così indifferente il mondo che non sai più come inventare la tua vita.
Non sarà la finzione a sfamare le tue voglie, e non sarà la pena a redimerti dai tuoi peccati.
Ti perderai, tra le velleità della tua incoscienza.
Non ritroverai la strada.
E allora, cosa cerchi adesso?

Straniamento
[poesia per progetto fotografico]
Guardala. Avvicinati. Non senti i suoi occhi sussurrarti le parole che non hai mai voluto ammettere?
Perditi nella sua pelle, nei contrasti prospettici, nelle ombre illusorie, nei magnifici grigi di una pelle rischiarata d’argento. E allora chiarisci anche i tuoi pensieri.
Sei reale?
No, non lo sono. Rispondi alle mie espressioni.
Mi sento. Ora la mente è incontrollabile, ma riconosco le mie domande.
Sono tra il bianco e il nero della mia vita, in attesa di risposte. Le mie.